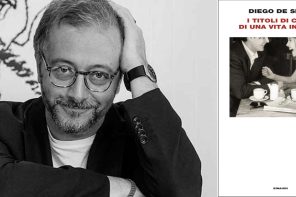L’eleganza sostenibile della bicicletta

Sul “Corriere d’informazione” del 10-11 aprile 1948, Alberto Savinio scriveva un breve elogio della bicicletta, tracciandone storia e filosofia con il suo sottile umorismo. Senza dimenticare di raccontare il rapporto profondo che ogni ciclista intrattiene con il proprio mezzo. Un rapporto fatto di “orgoglio e una qualche megalomania, ma c’è molto affetto soprattutto, molta fiducia e una legittima fierezza”, scrive Savinio, per poi aggiungere, fulminante, “Si sono viste biciclette lasciarsi morire sulla tomba del padrone”.
La bicicletta è, secondo lo scrittore, “fedele compagna” dell’uomo di studio e di pensiero, perché permette di stare “vicino alle cose”, dando però al passo del pensiero quel più di velocità che può assicurarne la qualità: ” Nietsche diffidava dei pensieri che ‘vengono in poltrona’ ai quali avrebbe dovuto contrapporre, come pensieri dei quali ci si può fidare a occhi chiusi, i pensieri che ‘vengono in bicicletta’”.
Nella giornata mondiale della bicicletta, proclamata dall’Onu nel 2018 per celebrare ogni 3 giugno un mezzo che è “un simbolo di trasporto sostenibile che trasmette un messaggio positivo per incoraggiare il consumo e la produzione sostenibile”, Memo pubblica un breve estratto di quell’articolo, intitolato “Gli uomini di pensiero tornano alla bicicletta”, raccolto in Scritti dispersi 1943-1952 (Adelphi, Milano 2004) e riproposto in una raffinata edizione dalla casa editrice Henry Beyle (Milano, 2014).
Una settantina di anni fa, Savinio decantava la bicicletta per la sua eleganza, “sorella dell’inutilità”, e dunque, sempre giocando sul filo del paradosso, per una “utilità superiore, inapparente ai più”; oggi noi, resi consapevoli dalla crisi climatica e dalla soglia di guardia raggiunta dall’inquinamento del pianeta, possiamo apprezzare la nuova eleganza della sua utilità. A vantaggio dell’ambiente e del benessere di tutti e di ciascuno. Soprattutto al tempo del coronavirus. (Claudia Ceccarelli)
[…] Come tutte le creazioni felici, la bicicletta è nata dalla grande, dalla feconda, dalla immortale idea del gioco. Anche le arti sono gioco e fanno tornare l’uomo al gioco, e non è strano che a chi le pratica o soltanto se ne diletta, conferiscano una aura di superiorità. È a scopo di divertimento che il francese Siorac pensò di porre due ruote una davanti all’altra, e unirle per mezzo di un travicello di legno. Poi montò a cavallo sul travicello, puntò i piedi per terra, spinse la macchina e cominciò a correre.
Ciò avveniva nel 1816, un anno dopo la battaglia di Waterloo. La relazione tra questi due fatti è importante. Senza la fine del napoleonismo, la bicicletta o non sarebbe nata, o sarebbe nata in un altro momento. La guerra, gioco massimo, assorbe in sé gli altri giochi.
Nel 1818, un tedesco di nome Drais aggiunse alla bicicletta il manubrio per la direzione e la sella per la comodità. E dal nome di lui la nuova macchina si chiamò Draisina, come dal nome di Guillotin la macchina per tagliar teste si chiama ghigliottina. Altri perfezionamenti recò alla biciletta nel 1855 il francesce Michaux, onde nacque quel famoso biciclo che aveva una grandissima ruota anteriore e una piccolissima ruota posteriore, e il cui ultimi esemplari non sopravvivono più se non in qualche teatro di varietà.
L’idea di tornare alle ruote di eguale circonferenza è dell’inglese Sargent, al quale si deve anche la catena per la trasmissione del moto alla ruota anteriore (la cosiddetta moltiplica). Anche la fasciatura delle ruote seguiva intanto una rapida evoluzione, e ai duri cerchioni di ferro primitivi, così poco confacenti ai prostatici e alla nature emorroidali, subentravano gli anelli di gomma piena e finalmente i pneumatici.
Pneumatico in Grecia chiamano il confessore, cioè a dire il curatore del pneuma, l’anima; ma nella storia del ciclismo il grande curatore dell’anima dei ciclisti è il veterinario inglese Dunlop, il quale, nel 1890, per fare cosa gradita al proprio figlio, che andando in bicicletta si lagnava che gli venivano le bolle e le budella gli balzavano in gola, ideò la camera d’aria, che tanta morbidezza ha recato al ciclismo e tanto sollievo al nostro sedere. […]