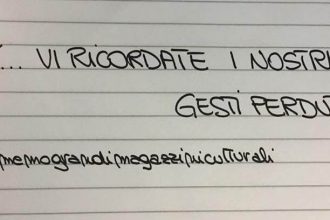L’hai voluta la bicicletta?
Allora pedala!
Ma senza fretta

Paolo Patui per lavoro insegna, per vocazione scrive e legge, per passione pedala. Da buon friuliano insomma non sta mai fermo. Ha creato la rassegna di resistenza letteraria LeggerMente; con Elio Bartolini ha scritto per il teatro Bigatis e ha tradotto in friulano per la RAI regionale le puntate di Lupo Alberto e della Pimpa. Dopo aver adattato al Friuli la Maratona di New York ha abbandonato la corsa a piedi a favore della bicicletta. Premio Etica per la Cultura 2012, ha recentemente pubblicato “La Scuola siamo noi”, diario eretico di un insegnante poco ortodosso. Il suo “Decalogo semiserio di un ciclista anomalo” (Ediciclo) è una divertente e appassionante dissertazione sulle acrobazie che un ciclista fa per evitare buche e automobili insieme ai tortuosi percorsi interiori con cui dribblare la fatica, soppesare le angosce, volare su cime che da terra non si oserebbe nemmeno immaginare. Perché solo in sella ad una bicicletta si attraversa il mondo con leggerezza e libertà. Per gentile concessione dell’editore Ediciclo pubblichiamo l’incipit. Buona lettura.
di Paolo Patui
Hai voluto la bicicletta? In realtà non mi ricordo se l’ho voluta o se me l’hanno imposta. Erano tempi in cui due erano i fattori che ti elevavano dalla condizione di bambino a quella di ragazzo capace di rivendicare un certo qual grado di autosufficienza: il primo consisteva nel dimostrare di sapersi muovere mantenendo uno stato di equilibrio poggiato su due malsicure ruote; il secondo nell’essere in grado di calzare un paio di pantaloni lunghi per un ragionevole lasso di tempo prima di sbucciarli all’altezzadelle ginocchia. Ovvero esattamente il contrario di quello che accade oggi, in cui la nostra generazione sul viale del tramonto prova a dare segnali di vitalità adolescenziale indossando nei mesi estivi imbarazzanti bregoni da cui fuoriesce un paio di polpacci glabri e più grassocci che muscolosi. Ma torniamo alla bici. Che l’abbia voluta o che me l’abbiano imposta come prova di iniziazione al mondo degli adulti, non lo so. Quello che so è che non appena ci sono salito e ho imparato a starci dritto non ne volevo più scendere. Anche se va detto che imparare all’unisono a muoversi con quell’arnese di ferro e rimanerci su, dritto, senza cadere è costato lacrime e fatica! Già, perché fin dall’inizio la bicicletta ti insegna, senza parlare, senza dire, senza proclamare che prima o poi di cadere ti toccherà. E che cadere fa male, sia che tu ti sbucci un ginocchio, sia che tu sbatta il muso sul cemento della strada o della vita. E come se non bastasse, passato il dolore, inghiottita l’umiliazione della caduta, tocca per forza rimettersi in piedi o in sella.
Rialzarsi costa fatica. E con la fatica i conti è meglio imparare a farli subito. Quell’oggetto metallicapparentemente muto, che già dovresti saper governare, te la sbatte subito in faccia la fatica, perché all’inizio è lei, la bicicletta, che governa te e ti porta dove vuole. Spesso pure a sbattere contro il muro che delimita casa tua, o contro l’unico palo di cemento nell’arco di un chilometro. A volte pure contro una macchina. Ferma, per fortuna.
Insomma vorresti governarla e invece non è così, tanto che ti pare che persino la velocità non sia frutto della tua volontà, semmai della dispettosità con cui, lei, quell’aggeggio a due ruote – sottilissime per altro – cerca di rendere precario l’equilibrio tuo e di ogni principiante. Tu ci sali e lei sbanda, tu ci sali e lei cade con te, tu ci sali e lei si impenna, tu ci sali e non sai come fermarla. E di certo nel corso di quell’umiliante e tremebondo rito di iniziazione, dall’imprevedibile durata a seconda dell’abilità del discepolo, a tutti noi è venuta prima o poi quella voglia bambina di prenderla a calci, di lasciarla lì, distesa in mezzo al cortile, quando ancora c’erano i cortili, in mezzo alla strada, quando la strada non era ancora una giungla rombante, persino in mezzo ai campi, quando i campi c’erano ed erano solcati da sentieri stretti quanto bastava perché ci passasse la ruota di una bicicletta. Ma poi quando hai cominciato a tenerne le redini, quando la tua testardaggine è stata più forte della sua dispettosità, hai imparato un po’ alla volta che grazie a quella serie di tubi metallici che ti stavano sotto al sedere ti era possibile andare con velocità relativa dove la voglia ti portava, e indirizzare quelle ruote nella direzione giusta. Insomma, quando hai scoperto la velocità con cui ti allontanavi da casa o il lampo con cui arrivavi là dove volevi, e poi le frenate con derapate, le accelerate con impennate… beh, allora hai capito che quella bici era una sorta di cavallo con le briglie sciolte verso la libertà. E hai ringraziato che te l’avessero data.
Con la bici sotto il sedere ho attraversato Udine in ogni direzione, sono stato a giocare su impensabili, improvvisati e pedonalmente lontanissimi campi da calcio, che a volte non erano nemmeno segnati, che spesso avevano lati e dimensioni talmente irregolari da renderli più simili a un trapezio spelacchiato che a un rettangolo di soffice verde. Con la bici sotto al sedere sono andato a scuola ogni giorno dell’anno, piovesse o non piovesse, ci fosse l’asfalto di Udine lucido di pioggia o brillante di sole, scivolando di lato e di dietro alle macchine ferme, in fila, dinanzi al rosso di un semaforo, sentendomi assolutamente libero di trasgredire ogni tipo di codice della strada e ogni regola di comportamento. Sulla bici ho cantato da solo o in compagnia. Sulla bici ho portato ragazze – desiderate e indesiderate – a casa e a scuola. Con la bici ho sentito la loro mancanza quando avevo bisogno di corrispondenza. Con la bici ho attraversato quasi ogni sera, al freddo o al caldo, le strade della mia città per andare dalla mia morosa, e per torna a casa a notte fonda. E quando Udine era buia, stanca, quasi silenziosa probabilmente il mio fischiettare, più che svegliare gli addormentati, fungeva da ninna nanna per gli insonni.
Poi è successo che quella bicicletta – che non era da corsa e nemmeno una mountain bike, e cosa fosse non lo saprei nemmeno definire perché, insomma, era la solita bici da uomo con cui un po’ tutti giravano per le strade, con il manubrio stretto e un unico cambio – è stata sostituita da altro. Questioni di età, di esperienze nuove e necessarie, fatte prima di palloni che rimbalzavano verso un canestro o verso una porta da calcio, poi di chitarre e idee ribelli, fino a scoprire che con la macchina era tutto un po’ più comodo. Ma poi, uscito dalla città per andare a vivere in mezzo alle colline moreniche, c’è stata la possibilità di riscoprire la seduzione della natura che aveva contrassegnato le mie giornate bambine. Solo che lì muoversi è tutto un saliscendi e per raggiungere un lago o per arrivare in cima a un colle da cui puoi guardare l’intero Friuli, se non hai la bici è dura. Oh sì, lo so, puoi fare come tanti, camminare, correre, ma i menischi non sono più quelli dei vent’anni e poi in tutta sincerità se scopri l’ebbrezza della pedalata veloce, del vento che ti schiaffeggia la faccia non tanto per la sua forza o per la sua intensità, quanto per la tua velocità, allora ti chiedi perché mai non ci sia più nessuno a dartela, la bici, adesso che la vuoi avere. E quando ne trovi una, quella bici torna a essere la tua compagna preferita. In certi momenti, d’accordo, vorresti non averla inforcata, perché ogni tanto dopo un lungo percorso la crisi della fatica ti attanaglia i muscoli, ti svuota di energia e vicino o distante che tu sia dal punto di arrivo, ti sembra comunque di non poterci arrivare; è vero, ti puoi anche fermare, ma mettere un piede a terra è sempre un po’ un segno di resa, una sconfitta che non si addice all’etica del ciclista. Perché i ciclisti un’etica ce l’hanno. E peggio ancora quando ti trovi all’improvviso su una rampa dalle pendenze impossibili, che non conoscevi né ti aspettavi, e ti sorge il sospetto che non si tratti solo di una rampa, ma di una salita intera, che ti farà piangere impotente, incapace di poter procedere. In quei momenti vorresti davvero buttare a terra tutto, sganciare gli scarpini a click clack, abbandonare la bici ovunque: in un fosso, sul ciglio della strada; vorresti appenderla persino ai rami che sporgono dal bosco ad accarezzare l’asfalto. Ma poi lo sai bene che quella bici l’hai voluta tu, quel percorso lo hai scelto e allora abbassi la testa e nella peggiore delle ipotesi cominci a caracollare con le spalle come non dovresti fare, come un vero ciclista non farebbe mai, ma nonmollare, arrivare, è così importante che poche volte come in questo caso dai ragione a Machiavelli: il fine giustifica i mezzi.
Anche qui la bicicletta ha il suo valore terapeutico, perché ti insegna ad affrontare la crisi a testa alta, a faccia aperta, senza protezione, perché la crisi viene in bicicletta, ma poi lo sappiamo bene che arriva addosso anche nella quotidianità; è quella voglia di mollare tutto, spesso proprio quando non sai che dopo quella curva in realtà ciò che volevi è a portata di mano. Lei, la bici, ti insegna che se molli a pochi metri dall’arrivo, a pochi metri dallo scollinamento, a pochi metri dalla discesa che ti farà rinascere, allora non valeva nemmeno la pena partire perché hai fatto un sacco di fatica per niente. La bici ti insegna a non mollare non solo quando sei sul percorso stradale, ma anche lungo il tuo percorso interiore, personale, esistenziale. Forse provocando scandalo sommo, sarei quasi portato a dire che è ben più maestra di vita lei che tanta scuola e tanta storia. E poi di crisi ce ne sono tante e di tanti tipi, dissertarne qui sarebbe probabilmente inopportuno, però anche queste parole che arrivano, queste pagine che seguono sono frutto di una fatica e di una piccola crisi interiore, non tanto per il ciclista quanto per lo scrittore, perché mettersi a nudo così non è semplice. Perché non scrivo da ciclista, perché non ragiono da ciclista, perché so che c’è gente che va in bicicletta molto più forte di me, molto più veloce di me, per molti chilometri più dei miei tempi infinitamente lunghi. Io parlo da misero ciclista un po’ anomalo, che non riesce mai ad anteporre completamente la prestazione agonistica all’aspetto della sua anima. Per cui: voi ciclisti veri, voi che mi superate continuamente sulle strade del Friuli, non prendetevela e non soppesate queste parole con il legittimo senso di superiorità che potete vantare. Accettatele come un punto di vista diverso e, come tale, sempre utile, perché magari capace di farvi percepire alcuni aspetti di questo nostro andare nomadi lungo le strade del Friuli che altrimenti potrebbero rimanere disconosciuti. Avrete tempo, incrociandomi lungo le strade, di fermarmi e spiegarmi i vostri punti di vista. Soprattutto se vi sarà capitato di leggere questo decalogo semiserio: dieci piccole avvertenze, dieci frammenti di vita in bicicletta, dieci riflessioni sgorgate dall’anima anomala di un ciclista qualunque ma non per questo qualunquista. E se mentre ne parleremo non riuscirò a stare al vostro passo, aspettatemi. Ci penserà la bici a portarvi lontano dopo la nostra chiacchierata. Prometto che non mi arrabbierò se, salutandomi veloci, ridenti e fuggitivi, mi direte: «Hai voluto la bici? Adesso pedala!».

“Decalogo semiserio di un ciclista anomalo” di Paolo Patui (Ediciclo Editore)
(https://www.ediciclo.it/)