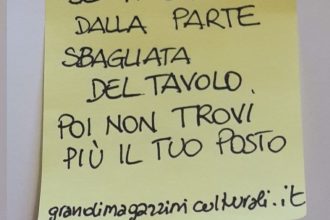Guarda che Luna!

Esattamente 50 anni fa, il 20 luglio 1969, l’uomo conquistò la Luna. In quel giorno d’estate, gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin, dopo quattro giorni di viaggio sulla navicella Apollo 11 con il collega Michael Collins, raggiunsero il satellite e, a bordo del modulo LEM, toccarono il suolo lunare. Le immagini di Armstrong e Aldrin a passeggio sulla Luna, una volta giunte sulla Terra, entrarono nel mito. Al primo fu attribuita la storica dichiarazione “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità”, che sintetizzava perfettamente il senso di tutta l’operazione.
Lo sbarco sulla Luna rappresentava, per i suoi sostenitori, il trionfo dell’intelligenza e del coraggio umano sui propri limiti. Scientifici, tecnologici, geografici. Il seguito ideale, a distanza di 500 anni, di quelle grandi esplorazioni che avevano spinto l’uomo occidentale alla scoperta di nuovi continenti.
Prima di allora, la Luna aveva sempre ispirato, nell’immaginario collettivo, emozioni di diverso tipo: da un lato romanticismo, malinconia, mistero, sogno, con la sua luce pallida adatta a illuminare i sentimenti più intimi; dall’altro spirito d’avventura, voglia di superare i confini del mondo conosciuto e di lanciarsi verso l’ignoto. Sia come simbolo immobile da contemplare, sia come destinazione geografica da raggiungere, da sempre scrittori, poeti, musicisti e registi hanno tratto ispirazione dalla Luna per le loro opere.
Nel campo della poesia, non si contano le composizioni dedicate alla Luna. A cominciare da Alla luna di Giacomo Leopardi (1820), in cui il Poeta dell’Infinito, contemplandola, si rivolge a lei come confidente dei propri tormenti intimi. Per passare al Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, sempre di Leopardi (1829-30), in cui il poeta, nelle vesti di un pastore, interroga la Luna sulla condizione umana, e sogna di fuggire volando via, ma senza ricevere risposta.
Charles Baudelaire, in Tristezza della luna (1857), la paragona a una bella donna triste e languida, a cui il poeta raccoglie una lacrima per sottrarla al sole, nascondendola nel cuore. Gabriele D’Annunzio, in O falce di luna calante (1882), racconta una Luna all’ultimo quarto pronta a mietere la messe di sogni che illumina col suo chiarore.
E si potrebbe continuare con un elenco lunghissimo di liriche, ognuna delle quali esprime un punto di vista e un sentimento unico.
Con la sua prosa, Jules Verne si spinse oltre, immaginando concretamente quello che sarebbe stato un vero e proprio viaggio sulla Luna. Con il suo dittico di romanzi fantascientifici Dalla Terra alla Luna (1865) e Intorno alla Luna (1870), lo scrittore francese anticipò lo storico allunaggio avvenuto circa un secolo dopo. Suggerì anche una durata del viaggio (97 ore e 20 minuti) poco distante dai quattro giorni di navigazione che occorreranno all’Apollo 11 per raggiungere il nostro satellite.
Circa trent’anni dopo, H.G. Wells, nel suo romanzo I primi uomini sulla Luna (1901), raccontò un altro viaggio sulla Luna, immaginandola abitata da esseri umanoidi dall’anatomia simile a quella degli insetti, che vivono in una società rigidamente classista.
Ed è proprio alla fantasia di Verne, e a quella sua contemporanea di Wells, che si ispirò liberamente Georges Méliès per il suo Viaggio nella Luna (1902), il primo film di fantascienza della storia del cinema, nonché uno dei capolavori dell’epoca del muto. La scena iniziale dell’astronave che si schianta sull’occhio della Luna, cavandolo, resta una delle sequenze più famose della storia della Settima Arte.
La cinematografia ispirata all’allunaggio non raggiunse più simili vette di fantasia, specialmente dopo che questo avvenne davvero. Di tutta la filmografia sull’argomento, tre rimangono i titoli più importanti: Capricorn One (1978) di Peter Hyams, che abbraccia la teoria cospirazionista secondo la quale la missione dell’Apollo 11 sarebbe stata un inganno orchestrato dalla NASA; Moon (2009) di Duncan Jones, dove la Luna è diventata una colonia terrestre dalla quale l’umanità del futuro estrae la sua principale fonte energetica; e il recente First Man – Il primo uomo (2018) di Damien Chazelle, biografia dell’astronauta Neil Armstrong che si concentra soprattutto sui fatti del 1969.
Ben più ampia è l’influenza che la Luna ebbe nel campo della musica, a cominciare dalla ninna nanna francese Au clair de la lune, risalente al XVIII secolo, il cui autore resta sconosciuto, e dalla Sonata per pianoforte n. 14 di Ludwig van Beethoven, più nota come Sonata al chiaro di luna, una delle composizioni pianistiche più famose di sempre, datata 1802.
Per restare al solo Novecento, la Luna è stata protagonista di innumerevoli canzoni. Iniziando da due intramontabili standard jazz: la malinconica Blue Moon, del 1934, che fu incisa da artisti leggendari quali Benny Goodman ed Ella Fitzgerald; e la romantica Fly Me to the Moon, del 1954, la cui versione più famosa fu cantata da Frank Sinatra. Immediatamente successive allo sbarco sono Bad Moon Rising (1969), brano rock dei Creedence Clearwater Revival con connotazioni apocalittiche, e la più rilassata Moondance (1971) di Van Morrison, il cui mood swing ricorda lo stile di Sinatra. Un discorso a parte merita l’album dei Pink Floyd The Dark Side of the Moon (1973), in cui la faccia oscura della Luna rappresenta una metafora di ciò che sfugge al controllo razionale dell’animo umano.
Nella musica italiana in tanti hanno cantato la Luna. Da Fred Buscaglione a Mina, da Gianni Togni a Loredana Bertè, da Pierangelo Bertoli e i Tazenda a Vasco Rossi, ognuno ha raccontato visioni strettamente personali e capaci di evocare atmosfere e sentimenti diversi.
Fabrizio De André, che citando Platone definiva in modo poetico gli omosessuali “figli della luna”, in maniera altrettanto poetica parla di “una luna morta piccola” nella drammatica rievocazione del massacro di un villaggio di nativi americani, visto dagli occhi di un bambino, in uno dei suoi capolavori, Fiume Sand Creek (1981).
E anche qui l’elenco potrebbe proseguire all’infinito.
Lo sbarco sulla Luna, si diceva, con tutto quello che la Luna rappresentava e tutt’ora rappresenta, è stato indubbiamente una grande conquista per l’uomo. Anche se forse non ebbe il seguito sperato, anche se qualcuno lo strumentalizzò per fini politici e anche se qualcun altro, tutt’oggi, continua a negare che sia avvenuto.
A noi piace ricordare come uno dei nostri poeti preferiti, Gianni Rodari, uno che era solito viaggiare negli spazi sconfinati della creatività, avesse anticipato di qualche anno, nella sua filastrocca Sulla luna, l’allunaggio dell’Apollo 11, esprimendo un’idea ben precisa sulle sue modalità. Un’idea che ci sentiamo di condividere, e con la quale salutiamo i lettori.
Sulla luna, per piacere,
non mandate un generale:
ne farebbe una caserma
con la tromba e il caporale.
Non mandateci un banchiere
sul satellite d’argento,
o lo mette in cassaforte
per mostrarlo a pagamento.
Non mandateci un ministro
col suo seguito di uscieri:
empirebbe di scartoffie
i lunatici crateri.
Ha da essere un poeta
sulla Luna ad allunare:
con la testa nella luna
lui da un pezzo ci sa stare…
A sognar i più bei sogni
è da un pezzo abituato:
sa sperare l’impossibile
anche quando è disperato.
Or che i sogni e le speranze
si fan veri come fiori,
sulla luna e sulla terra
fate largo ai sognatori!